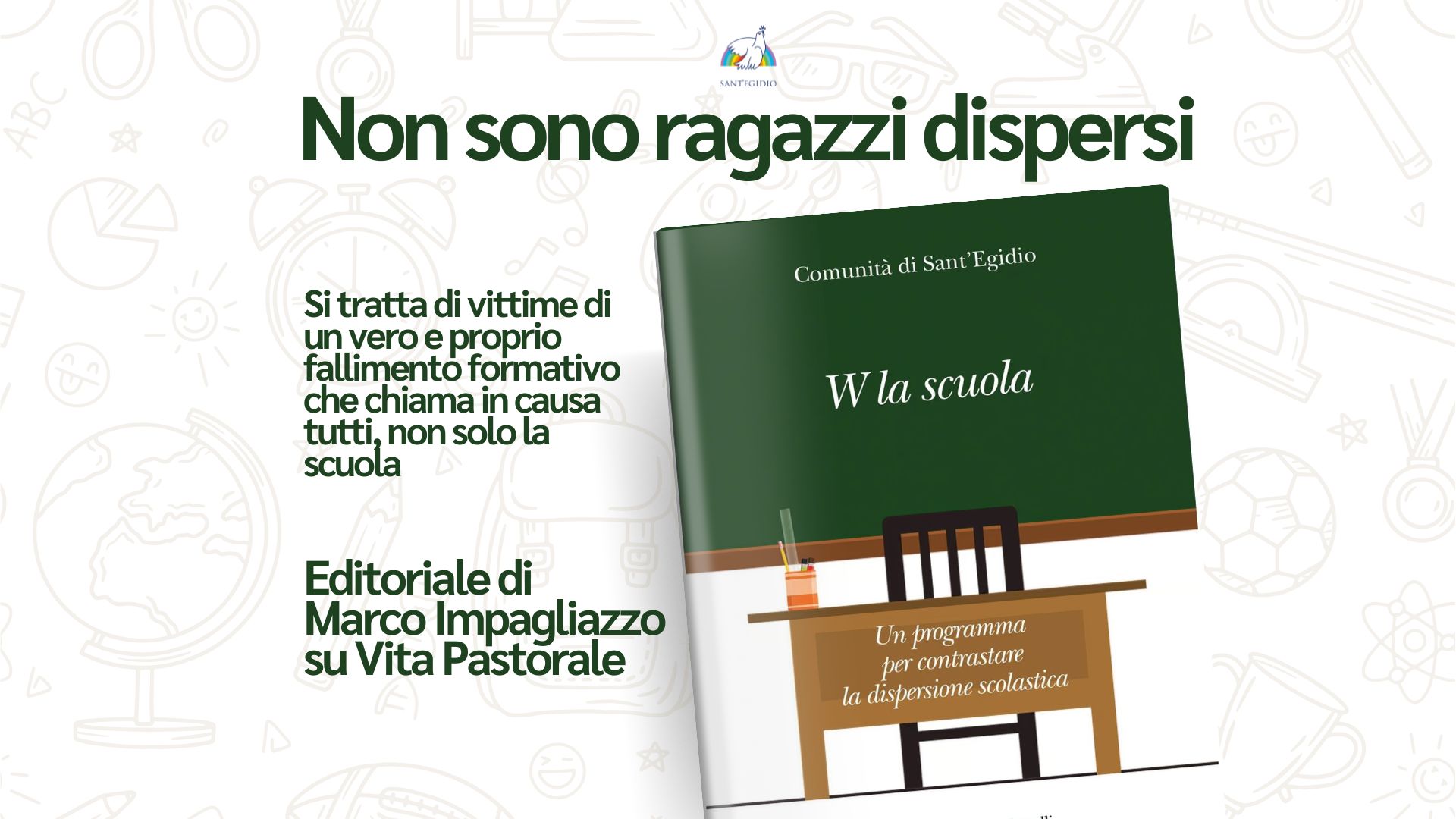Si tratta di vittime di un vero e proprio fallimento formativo che chiama in causa tutti, non solo la scuola
L'Italia conduce da tempo una battaglia contro la dispersione scolastica e la povertà educativa lungo una strada sulla quale, più di recente, s'è registrato un lieve miglioramento. I minori che abbandonano precocemente l'istruzione o la formazione sono all'incirca il 10,5% del totale. Nel confronto con gli altri paesi dell'Unione europea il nostro è ai primi posti per il numero di ragazzi che lasciano l'istruzione troppo presto. Il fenomeno è alto in particolare al Sud, nelle grandi città, ma non solo; specialmente tra i maschi e soprattutto tra quelli d'origine straniera rischiando di vanificare la spinta all'integrazione.
Per quanto ridimensionato, il fenomeno resta molto grave, perché la mancanza di un titolo di studio condannerà chi ha lasciato la scuola ad avere meno opportunità, perpetuando le disuguaglianze. Si tratta di una vera e propria spada di Damocle sospesa su una parte cospicua di intere generazioni, un danno alla crescita civile, culturale, economica del Paese, un ostacolo al raggiungimento di quella pienezza formativa necessaria al futuro dei nostri giovani.
Sono vari i fattori che contribuiscono alla dispersione e ne fanno un fenomeno decisamente complesso, che non si può pensare di contrastare solo con l'abnegazione dei docenti.
I bambini e i ragazzi che lasciano la scuola non sono da considerare "dispersi". La definizione è fuorviante. In realtà, sono persone comunque iscritte alle
nostre scuole, che dopo numerose assenze non ci sono andate più o ci vanno male o imparano pochissimo. Hanno un nome, un cognome, una paternità, una maternità, un indirizzo... Si tratta, allora, — ed è bene cominciare a chiamarlo col proprio nome — di un vero e proprio fallimento formativo. Lessicalmente, anche psicologicamente, chiamarli "dispersi" significa quasi dire che "se ne sono voluti andare". Dire che è un fallimento fonnativo chiama invece in causa tutti noi, non solo la scuola. E la società nella sua interezza, che deve sentire il bruciore di un'opportunità sottratta ai nostri figli, di un futuro rubato.
Ciò di cui c'è bisogno, allora, è un'azione sinergica che non lasci sola l'istituzione scolastica. Un'azione fatta di investimenti, ma anche di idee, di implementazione delle migliori pratiche già avviate per andare a cercare quanti si sono allontanati. Una di queste, iniziata nel gennaio 2022 dalla Comunità di Sant'Egidio, è il Programma "W la Scuola", per combattere la dispersione esplicita e implicita, particolarmente — ma non solo — nelle periferie delle grandi città.
Gli operatori del Programma, che abbiamo chiamato i "facilitatori scolastici", sono la chiave di volta dell'azione. Si tratta di una figura innovativa, incarnazione della prossimità, da sempre cifra peculiare di Sant'Egidio nella sua presenza solidale in situazioni difficili o marginali.
In contatto con alcune scuole di Roma, Napoli e Genova, i "facilitatori" instaurano un rapporto di collaborazione con gli istituti, i dirigenti e i docenti offrendo supporto a quei bambini e ragazzi che avevano smesso di frequentare o la cui frequenza a singhiozzo fa temere l'abbandono. L'intervento mira a ritessere il rapporto tra il minore, la sua famiglia, l'istituzione scolastica e ad affrontare i problemi nuovi, insorti dopo la pandemia, nonché quelli legati alla dipendenza dai social e dai device di ultima generazione, puntando a prevenire l'abbandono.
I "facilitatori scolastici" di "W la Scuola"si concentrano sulla storia di ciascun bambino o ragazzo segnalato dagli istituti scolastici, dalla famiglia o dai servizi sociali. L'intervento è supportato — se necessario — anche dalla presenza di un "mediatore linguistico" che, nei primi tempi, affianca in classe il bambino o il
ragazzo straniero appena arrivato in Italia. Questo, spesso, fa la differenza tra la percezione di un fallimento e il sogno di un futuro promettente. Il "facilitatore
scolastico", inoltre, ricerca risorse sul territorio che possano essere di aiuto, ascolta la famiglia, dialoga con gli insegnanti e si attiva per rispondere alle diverse esigenze del minore che ha di fronte.
Il Programma offre anche ai ragazzi più fragili, gratuitamente, un sostegno psicologico con un servizio di consulenze di professionisti volontari. Cerca, però, anche di costruire attorno a ogni ragazzo la possibilità di vincere quell'isolamento che, a volte, sigilla in una bolla di impossibilità, favorendo l'inserimento
dei giovani in attività di volontariato o convocandoli in momenti di socializzazione. Tutto questo fa emergere, gradualmente, nuove prospettive. Ognuno di questi ragazzi, se ha un'altra opportunità, ritrova le motivazioni per riprendere a studiare.
Mettere insieme una serie di figure educative con una forte alleanza, come accade nel Programma "W la Scuola", tra famiglia, società civile e istituti scolastici, vuoi dire creare comunità educanti. E quando c'è attorno a un bambino o a un ragazzo in difficoltà una comunità educante possono succedere dei miracoli: la frequenza già alle elementari aumenta, il rendimento migliora, i genitori sono fieri dei propri figli e si "attivano" per far continuare gli studi.
Ha scritto Massimo Recalcati: «Non possiamo sganciare l'istruzione dal processo educativo, cioè dell'umanizzazione della vita. La parola è la via di umanizzazione della vita».
L'obiettivo dell'educazione è l'umanizzazione della vita ed il Programma "W la Scuola" vuole contribuire a questo processo al cui centro c'è la necessità di
ascoltare e di parlare con ibambini e iragazzi per comprenderne le difficoltà e aiutarli a superarle.
[ Marco Impagliazzo ]