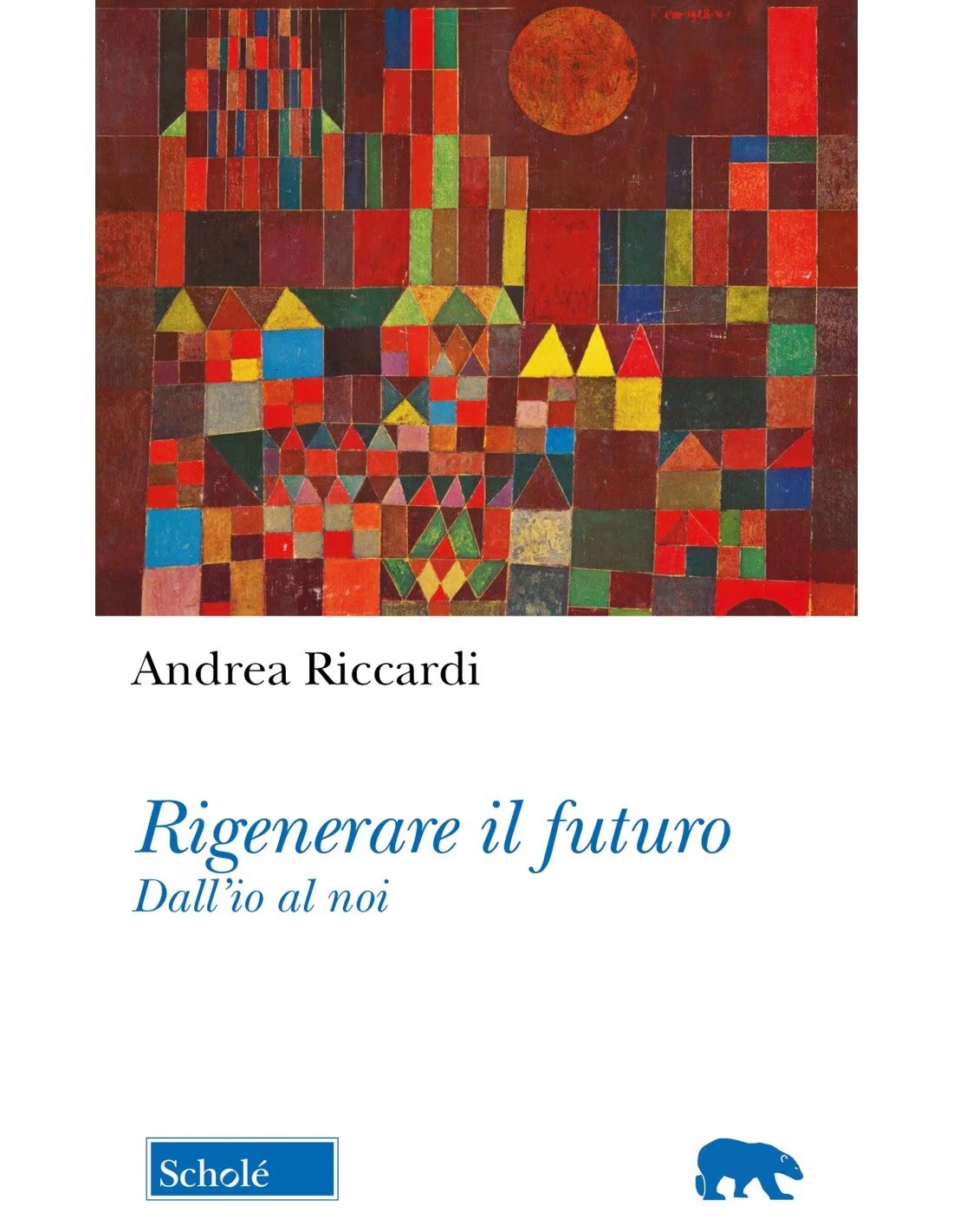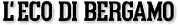L'incontro. Stasera Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio dialogherà con Pagnoncelli su «Come si fa la pace: le trattative positive»
Tra i fatti inattesi e tragicamente sorprendenti che hanno caratterizzato questo primo quarto del XXI secolo, due vanno certamente annoverati. In ordine cronologico, dapprima, la pandemia con le sue conseguenze: l'isolamento, le trasformazioni esistenziali, le malattie, la crisi economica, l'impatto devastante su giovani e anziani. Poi la riabilitazione della guerra come strumento di soluzione dei conflitti. Ben evidente, ci fosse bisogno di ricordarlo, dopo tante guerre in corso da anni dal Vicino Oriente all'Africa, con l'invasione russa dell'Ucraina che ha visto morire quasi duecentomila fra militari e civili ucraini e russi, e buttare via circa duecento miliardi, poco meno del «preventivo» - stimato da ricerche tedesche - di quanto costerebbe porre fine alla fame nel mondo. Invasione alla quale è seguita, dopo l'attacco del 7 ottobre 2023, la guerra di Gaza tra lo Stato di Israele e Hamas con un impressionante dossier di distruzioni e morti.
Ma, immersi in una società trasformata dalla globalizzazione e permeata da un estremo individualismo, come reagire davanti a questi scenari? E come non rimanere muti spettatori di queste vicende? Da queste considerazioni, si aprono le pagine del volumetto dello storico contemporaneista, nonché fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, edito da Morcelliana-Scholé con il titolo «Rigenerare il futuro. Dall'io al noi» (pagine 51, euro 10), che sviluppa una recente conferenza tenuta alla sede bresciana dell'Università Cattolica.
Ma, immersi in una società trasformata dalla globalizzazione e permeata da un estremo individualismo, come reagire davanti a questi scenari? E come non rimanere muti spettatori di queste vicende? Da queste considerazioni, si aprono le pagine del volumetto dello storico contemporaneista, nonché fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, edito da Morcelliana-Scholé con il titolo «Rigenerare il futuro. Dall'io al noi» (pagine 51, euro 10), che sviluppa una recente conferenza tenuta alla sede bresciana dell'Università Cattolica.
Riccardi questa sera alle 20.45 interverrà nell'Aula magna di Sant'Agostino, a Bergamo, in dialogo con Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, nell'ambito del percorso «Osare la pace in tempo di guerra», organizzato dall'associazione Mutuo Soccorso di Bergamo in collaborazione con «Molte fedi» (prenotazioni a [email protected] e sul sito www.moltefedi.it). L'incontro tratterà il tema «Come si fa la pace: le trattative positive».
Già nel titolo del libro, Riccardi prendendo atto del cambiamento culturale delineato da Jonathan Sacks, il noto rabbino recentemente scomparso, che aveva configurato nel passaggio dal «noi» all'«io» la premessa di una nuova visione dell'uomo e della donna come individui isolati, immessi in un vuoto relazionale, prova a indicare la risposta, senza ricette preconfezionate bensì rovesciando la prospettiva e l'approccio alla sfida rigenerativa proiettata nel domani: appunto «dall'io al noi». Che, tradotto, vuol dire passare dalla solitudine alla fratellanza.
Utopia? «Abbiamo tutti la forza di far propagare il sogno e non dobbiamo aspettare che il mondo cambi per operare un cambiamento. Ognuno può prendere un'iniziativa che generi un "noi"...», osserva Riccardi, sicuro che il futuro si declina ripartendo dal noi. Aggiungendo poco dopo - in piena sintonia con l'enciclica «Fratelli tutti» che «un processo di affratellamento, di amicizia sociale può iniziare, anche in situazioni locali, remote, dai rapporti tra le persone», indicando quindi come tema fondamentale nella ricostruzione del «noi» quello delle religioni come attori di fraternizzazione». Così già aveva intuito Giovanni Paolo II nell'Incontro interreligioso di Assisi nel 1986: un appuntamento da allora riproposto ogni anno dalla Comunità di Sant'Egidio nella convinzione che «le religioni in dialogo con le culture hanno molto da dire al nostro mondo». Ovvero, «possono creare comunità e tessere reti di socialità oppure alimentare conflitti e guerre». E in questo quadro è Papa Francesco a intravedere, insieme al pericolo di riporre ogni soluzione nel mercato, quello del cosiddetto «falso noi», fatto in realtà di tanti «io» isolati: il terreno antropologico in cui si sviluppano i populismi.
Una riflessione, quella di Riccardi, che si allarga nel libro concordando con alcune tesi di altri autori. Ad esempio Edgar Morin, quando sostiene che la fraternità, strumento di resistenza alle crudeltà del mondo, «deve diventare scopo, senza smettere di essere mezzo». O il primate della Chiesa Ortodossa di Albania, il quasi 95enne Anastasio, quando afferma che «il contrario della pace non è la guerra, ma l'egoismo» e quando spiega che «l'accettazione della guerra si sviluppa in un terreno di idolatria dell'"io", in una società senza visioni».
Non è tutto. Perché - scrive Riccardi - la fraternità che siamo chiamati a costruire deve essere «intergenerazionale», nonostante il nostro Paese, quello del lungo inverno demografico, non sembri volerlo. Tra anziani che non accettano di essere considerati tali e giovani che non trovano spazi. Da qui, il suo appello conclusivo a fare germinare una cultura di fraternità, a «far nascere sogni nel mondo globale, dove si sono spenti i fari dei grandi ideali capaci di mobilitare le energie migliori».
Già nel titolo del libro, Riccardi prendendo atto del cambiamento culturale delineato da Jonathan Sacks, il noto rabbino recentemente scomparso, che aveva configurato nel passaggio dal «noi» all'«io» la premessa di una nuova visione dell'uomo e della donna come individui isolati, immessi in un vuoto relazionale, prova a indicare la risposta, senza ricette preconfezionate bensì rovesciando la prospettiva e l'approccio alla sfida rigenerativa proiettata nel domani: appunto «dall'io al noi». Che, tradotto, vuol dire passare dalla solitudine alla fratellanza.
Utopia? «Abbiamo tutti la forza di far propagare il sogno e non dobbiamo aspettare che il mondo cambi per operare un cambiamento. Ognuno può prendere un'iniziativa che generi un "noi"...», osserva Riccardi, sicuro che il futuro si declina ripartendo dal noi. Aggiungendo poco dopo - in piena sintonia con l'enciclica «Fratelli tutti» che «un processo di affratellamento, di amicizia sociale può iniziare, anche in situazioni locali, remote, dai rapporti tra le persone», indicando quindi come tema fondamentale nella ricostruzione del «noi» quello delle religioni come attori di fraternizzazione». Così già aveva intuito Giovanni Paolo II nell'Incontro interreligioso di Assisi nel 1986: un appuntamento da allora riproposto ogni anno dalla Comunità di Sant'Egidio nella convinzione che «le religioni in dialogo con le culture hanno molto da dire al nostro mondo». Ovvero, «possono creare comunità e tessere reti di socialità oppure alimentare conflitti e guerre». E in questo quadro è Papa Francesco a intravedere, insieme al pericolo di riporre ogni soluzione nel mercato, quello del cosiddetto «falso noi», fatto in realtà di tanti «io» isolati: il terreno antropologico in cui si sviluppano i populismi.
Una riflessione, quella di Riccardi, che si allarga nel libro concordando con alcune tesi di altri autori. Ad esempio Edgar Morin, quando sostiene che la fraternità, strumento di resistenza alle crudeltà del mondo, «deve diventare scopo, senza smettere di essere mezzo». O il primate della Chiesa Ortodossa di Albania, il quasi 95enne Anastasio, quando afferma che «il contrario della pace non è la guerra, ma l'egoismo» e quando spiega che «l'accettazione della guerra si sviluppa in un terreno di idolatria dell'"io", in una società senza visioni».
Non è tutto. Perché - scrive Riccardi - la fraternità che siamo chiamati a costruire deve essere «intergenerazionale», nonostante il nostro Paese, quello del lungo inverno demografico, non sembri volerlo. Tra anziani che non accettano di essere considerati tali e giovani che non trovano spazi. Da qui, il suo appello conclusivo a fare germinare una cultura di fraternità, a «far nascere sogni nel mondo globale, dove si sono spenti i fari dei grandi ideali capaci di mobilitare le energie migliori».
[ Elisa Roncalli ]