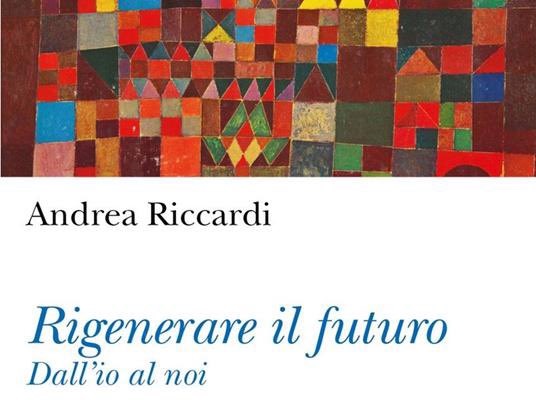Società. Andrea Riccardi lancia un forte allarme nel suo nuovo libro «Rigenerare il futuro» (Scholé)
Crescono i disturbi mentali e le difficoltà relazionali nei soggetti più giovani e fragili. Nell'Italia di oggi circa un terzo dei nuclei familiari è composto da una sola persona
Una grande figura dell'ebraismo britannico, il rabbino Jonathan Sacks, recentemente scomparso, ha parlato di un cambiamento climatico-culturale, ovvero il passaggio dal «noi» all'«io». A partire dalla fine del secolo scorso, abbiamo vissuto un esodo profondo, talvolta impercettibile e tuttavia drammatico, verso il mondo dell'«io» che ha generato una nuova visione dell'uomo e della donna come individui isolati, immessi in un vuoto relazionale, quasi si trattasse di una condizione di normalità.
Luigi Zoja, noto sociologo e psicanalista, ha parlato di «morte del prossimo» a proposito della crisi dei rapporti umani e sociali. Sintomo evidente di questo cambiamento è il calo del volontariato in Italia, che dal 2015 al 2021 ha visto una progressiva diminuzione della partecipazione: da 5,5 milioni si è passati a 4,6 milioni di persone.
Mattia Ferraresi, attento osservatore della società, ha scritto che il nostro mondo è quello «delle pubblicità profilate, dei pasti monoporzione, del selfie, della condizione di single come stato sommamente desiderabile», un mondo, insomma, dove a regnare è la solitudine. Siamo di fronte a «qualcosa di più complicato e oscuro di una propensione sociale: è lo stato esistenziale dell'uomo contemporaneo».
Solitudine come condizione normale ma allo stesso tempo come epidemia: basti pensare alle malattie mentali o alle tante difficoltà relazionali ed esistenziali dei più giovani. L'emersione della solitudine come patologia non rappresenta altro che l'approdo estremo di una vita tutta centrata sull'«io». Sacks ha scritto: «Non possiamo restare in questa situazione, perché il mondo degli uomini sta diventando sempre più freddo e i venti sempre più sferzanti e taglienti. Abbiamo bisogno di un poco più di Noi e un po' meno di Io, se dobbiamo districarci tra alcune delle sfide che il secolo attuale ha in serbo ancora per noi».
Lo slittamento dal «noi» all'«io» ha portato a una desertificazione della vita che persiste persino nei momenti difficili dell'esistenza. La fragilità, la vecchiaia, l'impoverimento mettono in luce come in queste condizioni l'«io» non basta. Chiediamoci per esempio cosa voglia dire essere bambini o adolescenti in un vuoto di relazioni. Nel linguaggio burocratico, il ragazzo emigrato senza la sua famiglia - una realtà che sta diventando sempre più comune - viene chiamato con una espressione che sembra quasi una metafora: «minore non accompagnato».
La richiesta di uscire da una condizione di solitudine che ormai viene avvertita come normale, non si è però spenta. Eppure otto milioni e mezzo di italiani vivono soli. Un terzo dei nuclei familiari è composto da una sola persona. In questa condizione «normale» si sente un grido di dolore, forse più di uno. Innanzitutto quello degli anziani, spesso provenienti da una storia di famiglie numerose, che non ce la fanno a vivere soli: si pensi all'emblematica vicenda delle Rsa, che durante la pandemia di Covid ha messo in luce il dramma dell'abbandono con migliaia di anziani deceduti nella più totale solitudine.
Il crescente disagio dei più giovani, invece, difficilmente diventa grido, perché spesso le loro parole e i loro sentimenti vengono oscurati dal protagonismo di una generazione di adulti che non vuole invecchiare e lasciare spazio ad altri. La nostra è una società che non solo non fa posto ai giovani ma neppure ha un futuro da proporre loro. Walter Brueggemann, teologo nordamericano, scrive invece che la realizzazione di un sogno non può essere mai unigenerazionale. Un sogno per essere tale deve appartenere a più generazioni. L'Italia della ricostruzione dopo la Seconda guerra mondiale, per esempio, era animata da un progetto che univa più generazioni in vista del futuro.
L'enciclica Fratelli tutti, una proposta maturata nel tempo della pandemia, parla di una coscienza isolata dell'uomo e della donna di oggi e poi aggiunge: «Un modo efficace di dissolvere la coscienza storica, il pensiero critico, l'impegno per la giustizia e i percorsi di integrazione è quello di svuotare di senso o alterare le grandi parole. Che cosa significano oggi alcune espressioni come democrazia, libertà, giustizia, unità?». E' un'osservazione molto acuta sul nostro tempo, perché queste espressioni, che per decenni sono state interpretate anche in modo contrapposto a seconda delle ideologie, hanno rappresentato veri e propri fari per l'umanità, dal secondo dopoguerra alla decolonizzazione e sino alla fine delle dittature. Oggi questi fari non illuminano più il futuro, si sono spenti: le visioni, infatti, richiedono un «noi» condiviso, come punto di partenza.
L'Europa oggi soffre per una mancanza di visione, anche perché la nostra politica ha clamorosamente divorziato dalla cultura, alleandosi prima con la televisione e poi con il mondo dei social. Del resto un mondo fatto di tanti «io» vive una politica diversa, fatta di polarizzazioni estreme ed emotive, di rifiuto dell'impegno civico oppure di ricerca di leader rassicuranti in senso populista.
Luigi Zoja, noto sociologo e psicanalista, ha parlato di «morte del prossimo» a proposito della crisi dei rapporti umani e sociali. Sintomo evidente di questo cambiamento è il calo del volontariato in Italia, che dal 2015 al 2021 ha visto una progressiva diminuzione della partecipazione: da 5,5 milioni si è passati a 4,6 milioni di persone.
Mattia Ferraresi, attento osservatore della società, ha scritto che il nostro mondo è quello «delle pubblicità profilate, dei pasti monoporzione, del selfie, della condizione di single come stato sommamente desiderabile», un mondo, insomma, dove a regnare è la solitudine. Siamo di fronte a «qualcosa di più complicato e oscuro di una propensione sociale: è lo stato esistenziale dell'uomo contemporaneo».
Solitudine come condizione normale ma allo stesso tempo come epidemia: basti pensare alle malattie mentali o alle tante difficoltà relazionali ed esistenziali dei più giovani. L'emersione della solitudine come patologia non rappresenta altro che l'approdo estremo di una vita tutta centrata sull'«io». Sacks ha scritto: «Non possiamo restare in questa situazione, perché il mondo degli uomini sta diventando sempre più freddo e i venti sempre più sferzanti e taglienti. Abbiamo bisogno di un poco più di Noi e un po' meno di Io, se dobbiamo districarci tra alcune delle sfide che il secolo attuale ha in serbo ancora per noi».
Lo slittamento dal «noi» all'«io» ha portato a una desertificazione della vita che persiste persino nei momenti difficili dell'esistenza. La fragilità, la vecchiaia, l'impoverimento mettono in luce come in queste condizioni l'«io» non basta. Chiediamoci per esempio cosa voglia dire essere bambini o adolescenti in un vuoto di relazioni. Nel linguaggio burocratico, il ragazzo emigrato senza la sua famiglia - una realtà che sta diventando sempre più comune - viene chiamato con una espressione che sembra quasi una metafora: «minore non accompagnato».
La richiesta di uscire da una condizione di solitudine che ormai viene avvertita come normale, non si è però spenta. Eppure otto milioni e mezzo di italiani vivono soli. Un terzo dei nuclei familiari è composto da una sola persona. In questa condizione «normale» si sente un grido di dolore, forse più di uno. Innanzitutto quello degli anziani, spesso provenienti da una storia di famiglie numerose, che non ce la fanno a vivere soli: si pensi all'emblematica vicenda delle Rsa, che durante la pandemia di Covid ha messo in luce il dramma dell'abbandono con migliaia di anziani deceduti nella più totale solitudine.
Il crescente disagio dei più giovani, invece, difficilmente diventa grido, perché spesso le loro parole e i loro sentimenti vengono oscurati dal protagonismo di una generazione di adulti che non vuole invecchiare e lasciare spazio ad altri. La nostra è una società che non solo non fa posto ai giovani ma neppure ha un futuro da proporre loro. Walter Brueggemann, teologo nordamericano, scrive invece che la realizzazione di un sogno non può essere mai unigenerazionale. Un sogno per essere tale deve appartenere a più generazioni. L'Italia della ricostruzione dopo la Seconda guerra mondiale, per esempio, era animata da un progetto che univa più generazioni in vista del futuro.
L'enciclica Fratelli tutti, una proposta maturata nel tempo della pandemia, parla di una coscienza isolata dell'uomo e della donna di oggi e poi aggiunge: «Un modo efficace di dissolvere la coscienza storica, il pensiero critico, l'impegno per la giustizia e i percorsi di integrazione è quello di svuotare di senso o alterare le grandi parole. Che cosa significano oggi alcune espressioni come democrazia, libertà, giustizia, unità?». E' un'osservazione molto acuta sul nostro tempo, perché queste espressioni, che per decenni sono state interpretate anche in modo contrapposto a seconda delle ideologie, hanno rappresentato veri e propri fari per l'umanità, dal secondo dopoguerra alla decolonizzazione e sino alla fine delle dittature. Oggi questi fari non illuminano più il futuro, si sono spenti: le visioni, infatti, richiedono un «noi» condiviso, come punto di partenza.
L'Europa oggi soffre per una mancanza di visione, anche perché la nostra politica ha clamorosamente divorziato dalla cultura, alleandosi prima con la televisione e poi con il mondo dei social. Del resto un mondo fatto di tanti «io» vive una politica diversa, fatta di polarizzazioni estreme ed emotive, di rifiuto dell'impegno civico oppure di ricerca di leader rassicuranti in senso populista.
* Il libro di Andrea Riccardi: Rigenerare il futuro. Dall'io al noi, è pubblicato dall'editrice Scholé (pagine 51, €10)
• Tra i libri recenti di Riccardi: La guerra del silenzio (Laterza, 2022); La Chiesa brucia (Laterza, 2021); Italia carismatica (Morcelliana, 2021)
[ Andrea Riccardi ]